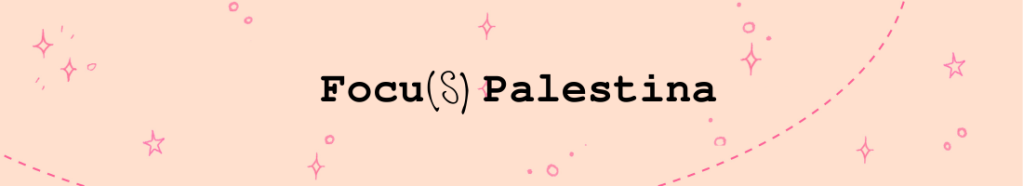
Focus Palestina è una rubrica della newsletter mensile di Mis(S)conosciute – Scrittrici (e altre cose) tra parentesi dedicata alla letteratura palestinese in cui le autrici e curatrici del progetto divulgativo Oriental Book Club raccontano ogni mese una scrittrice palestinese da scoprire.
La scrittrice: Samira Azzam
Quando si chiede ad Adania Shibli di parlare di Samira Azzam, a lei viene in mente il suo orologio. Un’associazione bizzarra, se non fosse che The Clock and the Man (الساعة والإنسان – al-Sāʿa wa-’l-ʾinsān) è il titolo di un racconto di Azzam, contenuto nell’omonima raccolta di short stories. L’orologio e l’uomo è, infatti, l’unico testo ad essere autorizzato nei programmi scolastici di letteratura araba dal Bureau di Censura Israeliano.

Il racconto, pubblicato nel 1963, parla di un giovane che si prepara ad andare a dormire la sera prima del suo primo giorno di lavoro. Imposta la sveglia alle quattro del mattino per prendere il treno in tempo per andare al lavoro. Non appena la sveglia suona la mattina seguente, qualcuno bussa alla sua porta. Quando la apre, trova un vecchio davanti a lui. Non ha idea di chi sia quest’uomo e non ha la possibilità di chiederglielo, perché il vecchio si gira e se ne va, scomparendo nell’oscurità. Questo si ripete giorno dopo giorno, tanto che il giovane smette di impostare la sveglia. Solo diversi mesi dopo scopre chi è il vecchio, dopo che un collega gli dice che quell’uomo andava a bussare alle porte di tutti i dipendenti dell’azienda. Li svegliava per non far loro perdere il treno e subire lo stesso destino di suo figlio. Una mattina suo figlio era arrivato tardi alla stazione, proprio mentre il treno stava partendo. Si aggrappò alla porta del treno, ma la sua mano lo tradì e scivolò, cadendo sotto le ruote del treno.
A prima vista, questa storia potrebbe sembrare semplice e sicura, specialmente agli occhi dei censori. Ma contribuì a plasmare la mia coscienza riguardo alla Palestina come nessun altro testo che avessi mai letto. C’erano una volta dipendenti palestinesi che andavano al lavoro in treno? C’era una stazione ferroviaria? C’era una volta un treno che fischiava in Palestina? C’era mai stata una vita normale in Palestina? E allora dov’è adesso, e perché è svanita?
(fonte, trad. Giulia Seclì)
Samira Azzam (13 settembre 1927 – 8 agosto 1967) è stata una scrittrice, giornalista, traduttrice e speaker radiofonica palestinese nata ad Acri da una famiglia cristiano-ortodossa. Soprannominata la Shahrazād palestinese, con i suoi racconti è riuscita a dare voce ed analizzare l’identità e la società palestinesi nel suo complesso.
Frequenta le scuole ad Haifa e a 16 diventa insegnante, prima di iniziare a scrivere alcuni articoli per il giornale Filistin con lo pseudonimo di Ragazza della costa. Durante la Nakba (la “catastrofe”) del 1948, come molte e molti palestinesi, è costretta a lasciare la sua terra e a stabilirisi con la sua famiglia in Libano.
Nel 1950 si trasferisce in Iraq dove diventa direttrice di una scuola femminile e inizia la sua carriera in radio per la Near East Asia Broadcasting Company, per la quale si occupa di scrivere i testi del programma Women’s corner. Da qui viene trasferita a Beirut, divenendo la penna e la voce dietro al programma In the Morning, per poi ritornare nuovamente in Iraq insieme al marito per un breve periodo durante il 1959. Il soggiorno iracheno, però, dura poco: l’appena nato regime di stampo republicano – che aveva rovesciato la monarchia con un colpo di stato il 14 luglio 1948 – accusa i programmi radiofonici di Azzam di aperta ostilità nei confronti del regime e la scrittrice è costretta a ritornare ancora una volta a Beirut insieme alla famiglia.
La scrittura accompagna tutta la vita di Samira Azzam, che solo in un primo momento si occupa di questioni femminili, per poi allargare lo sguardo sulla società palestinese del post-Nakba, accrescendo la propria consapevolezza sulla complessità della situazione in cui la sua gente era stata scaraventata ed evidenziando l’impegno politico nei suoi scritti.
Quello che Azzam fa con la sua scrittura è descrivere l’impatto della Nakba sulla vita dei palestinesi, arricchendo i racconti di dettagli minori e delineando personaggi profondamente realistici, che si trovano a dover affrontare situazioni inimmaginabili con comportamenti inaspettati.
La scrittrice, poi, non si tira indietro quando si tratta di mettere in scena quanto l’oppressione e la discriminazione del popolo palestinese pesi doppiamente sulle spalle delle donne, oppresse e discriminate per l’identità nazionale e di genere.
La lucidità con cui la scrittrice riesce a riportare le cause dell’agire e del subire della gente comune nei suoi racconti alla complessità della società palestinese prima e alla situazione generale della Palestina dopo il 1948 poi, rendono i racconti della Azzam modernissimi. Le figure femminili, sempre forti e indipendenti, non sono mai slegate dai contesti che abitano fuori e dentro le pagine e, anzi, ancora prima delle contemporanee riflessioni femministe, la scrittrice ha saputo raccontare la marginalizzazione delle donne palestinesi attribuendola al sistema sociale, culturale e politico e non al singolo individuo.
Soprattutto nei racconti successivi, Samira Azzam rende manifesti i suoi intenti politici: le storie prendono il via da una situazione ben precisa in cui i protagonisti devono compiere delle scelte decisive per la propria sopravvivenza e la loro azione nel racconto diventa l’allegoria della lotta politica palestinese, contornandosi di tutti quei temi che ritroviamo nella letteratura palestinese (l’espropriazione, l’identità, la speranza, la terra, il senso di appartenenza, la nostalgia…).
La produzione letteraria di Samira Azzam copre il periodo tra il 1948 e il 1967, ma ancora troppo poco è arrivato in traduzione italiana. Le sue opere edite, tutte raccolte di racconti, sono cinque:
- ʾashyā’ saġīra (أشياء صغيرة – Piccole cose) del 1954
- Al-ẓill al-kabīr (الظل الكبير – La grande ombra) del 1956
- Wa-qiṣaṣ ʾuḫrā (وقصص أخرى – E altri racconti) del 1960
- Al-sāʿa wa-’l-ʾinsān (الساعة والإنسان – L’orologio e l’uomo) nel 1963
- Al-ʿīd min ḫalāl al-nāfiḏa al-ġarība (العيد من خلال النافذة الغريبة – La festa dalla finestra occidentale), pubblicato postumo nel 1971.
Durante gli anni Sessanta si dedicò alla stesura di un romanzo, سيناء بلا حدود (Sīnā’ bilā ḥudūd – Sinai senza confini), poi distrutto alla notizia della sconfitta degli arabi durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Immaginiamo la scrittrice, che credeva nel potere della parola e delle storie, apprendere con amarezza e rassegnazione la notizia della disfatta, che non a caso tra gli arabi è nota come al-Naksa (النكسة – la sconfitta). Gli stessi sentimenti circolano in questi giorni sui media arabi, secondo cui la situazione a Gaza è considerata un’infelice coda della vittoria israeliana nella Guerra dei Sei Giorni (fonte).
Samira Azzam muore a 39 anni, per un attacco cardiaco avvenuto l’8 agosto del 1967, e probabilmente per questo viene messa in ombra da romanzieri e poeti che dal 1967 in poi sono diventati un punto di riferimento per la letteratura e la lotta palestinese. Lei per prima, però, riesce a comporre con le sue storie un vero e proprio trattato sociologico sul popolo palestinese prima e dopo la Nakba:
Attraverso i suoi scritti, ha dimostrato che l’esperienza umana è complessa e sfaccettata, e che non c’è spazio per dicotomie riduttive quando si tenta di catturare la realtà. Era consapevole dell’impatto della lingua sulla vita delle persone comuni ed era particolarmente capace di trasmettere pienamente le sofferenze delle donne, il loro desiderio di libertà, di lavoro e di cibo.
[…]
Ingannevoli nella loro semplicità, i racconti di Azzam sono a loro volta avvincenti, strazianti e stimolanti. Le sue storie necessitano di un ulteriore esame letterario poiché non narrano eventi specifici quanto catturano l’essenza della vita quotidiana. Tuttavia, la sua analisi della psiche umana è niente meno che magistrale, con personaggi multidimensionali pronti a esistere oltre la pagina in tutte le loro sfumature profonde e sottili.
(Ibrahim Fawzy, fonte, trad. di Giulia Seclì)
Ghassan Kanafani definiva Samira Azzam “la mia maestra” e infatti la sua bravura e la sua eredità sono ora riconosciute da scrittori e critici letterari, ma è necessario fare ancora uno sforzo per vederle occupare il posto che merita all’interno del canone letterario palestinese e mondiale.
L’opera: Palestinese! E altri racconti
Palestinese! E altri racconti è la prima antologia tradotta in italiano di Samira Azzam. Una prima edizione risale al 2003, mentre quella che è attualmente reperibile è la terza edizione rivista e ampliata nel 2014 con due racconti (Trilli e Un anno ancora) già pubblicati in Italia, rispettivamente in Linea d’ombra (1991) e Scrittori arabi del Novecento (2002) e per questo esclusi dalla prima edizione di questa raccolta, e da un’ulteriore sezione di testi lasciati inediti dall’autrice e pubblicati postumi.
In totale i racconti brevi raccolti in questa edizione sono ventidue.
La storia che dà il titolo alla raccolta è Palestinese!, che ruota intorno al concetto di identità, ma in queste poche pagine i temi che si intrecciano sono molti, tutti diventati topoi letterari della letteratura palestinese.
La narrazione inizia in medias res: un bottegaio chiede a un cliente di mostrargli la propria carta di identità. Le sue intenzioni sono quelle di confrontarla con la propria, da poco ricevuta.
Ma che te ne fai della mia carta d’identità, Palestinese!
Il protagonista di questo racconto è senza nome. Tutti infatti lo conoscono e lo chiamano con l’appellativo “Palestinese” ed è evidente il tono di disprezzo con cui gli abitanti del quartiere lo pronuncino.
Il fulcro della vicenda è rappresentato dal suo tentativo di ottenere un documento libanese che permetta, a lui e alla sua famiglia, di lasciare il Paese. In passato gli si sono presentate davanti diverse occasioni ed escamotage per poterlo ottenere, ma per un motivo o per un altro non ha mai fatto il passo decisivo.
Un giorno varca la soglia del negozio un uomo in completo blu per comprare una scatola di fiammiferi. Completato l’acquisto, lo sconosciuto si trattiene sull’entrata a fumare.
Quasi come se leggesse nella mente al Palestinese, l’uomo in completo propone al negoziante un affare: gli avrebbe procurato i documenti di cui aveva bisogno alla cifra di duemila denari.
Si trattava chiaramente di una carta d’identità falsa.
Qualche tempo dopo, il Palestinese riconosce in prima pagina il volto dei falsari con cui aveva fatto il suo accordo. Un componente della banda aveva confessato.
Nonostante fosse evidente che i documenti erano falsi, all’improvviso il commerciante da vittima di soprusi, obbligato letteralmente a “fare carte false” per poter godere delle basilari libertà di un individuo, inizia a sentirsi complice.
Il dubbio di stracciare o meno la prova del suo misfatto lo attanaglia, finché una cliente del piano di sopra lo chiama con insistenza per avere una bibita, senza ottenere risposta.
-Ehi, ragazzo! Dì al Palestinese di mettermi una coca cola nella cesta!-
Della carta d’identità rimarranno solo pezzetti nella sua tasca.
Era primavera. La primavera, in Palestina, di giorno è fatta di mare azzurro solcato dalle vele bianche ed è intarsiata, di notte, dalle lanterne dei pescherecci, l’aria infittita dal profumo degli aranceti… In quella sua primavera la Palestina ha conosciuto due cose, l’amore e la guerra. E il primo dava significato alla seconda. La guerra, in Palestina, non è il nemico che si uccide per caso, è invece il diritto alla vita della terra che si ama. E della ragazza che si ama. La Palestina non è solo il mare e le barche dei pescatori, non è solo arance pendenti come pomi d’oro, non è solo olive e olio che riempiono le giare. E anche gli occhi neri di Suàd, e negli occhi di Suàd vide tutto il bene della Palestina. Vide l’ombra di una sua casa felice e di una moglie che gli dava piccoli eroi e che col suo amore dava senso alla sua vita.
Nel racconto Il pane, da cui è tratta questa citazione, il tema della guerra e dell’amore si intrecciano.
Un giovane miliziano e un’infermiera si innamorano durante i loro turni di notte. I loro sentimenti sbocciano durante la Nakba e fioriscono durante i brevi momenti di scambio che riescono a ritagliarsi durante le veglie e i loro incarichi.
La banalità dei loro gesti, lo sfiorarsi delle dita, il soffermarsi di uno sguardo, diventano eroici di fronte allo scenario bellico, ai feriti, ai bombardamenti, alla distruzione delle città vicine ad Akka, o San Giovanni d’Acri, città natale di Samira Azzam.
Il racconto prende il titolo dalla conclusione di questa storia d’amore in tempo di guerra.
Suad incontra fugacemente Ramiz durante un approvvigionamento di vettovaglie. Lui si sta lavando il viso, ma non riesce neppure a togliersi il sapone dagli occhi. Spari nelle vicinanze. Suad e Ramiz incrociano i loro sguardi. Lei porta tra le braccia del pane, quando cade e muore senza riuscire a pronunciare neppure una parola, solo un rantolo sordo e la loro storia è finita.
Passano i giorni e il manipolo di soldati di cui fa parte Ramiz è rimasto senza cibo. Sfiniti si nascondo per evitare di essere intercettati e uccisi. Il pane di Suad giace ancora intatto e avvolto da un panno. Nessuno osa toccarlo. Nessuno osa toccare quel pane imbevuto e macchiato di sangue. Morirebbero tutti di fame piuttosto che avventarsi su quelle provviste consacrate dal sangue dell’infermiera Suad.
E con la loro morte certo non l’avrebbero vendicata! Vendicare la morte di lei? Già, come aveva potuto dimenticarlo? Come aveva potuto scegliere di morire come un cane e di far morire con lui cinque persone? L’essere stato più volte a contatto con la morte aveva reso forse quel pensiero meno inaccettabile. Comunque, se pure avesse avuto il diritto di scegliere come morire, certo non sarebbe stata la morte per fame. La stessa Suad non l’avrebbe voluto.
Alla fine Ramiz prende coraggio e spezza il pane insieme ai suoi compagni, per poi perdere i sensi.
Tra i motivi ricorrenti nei racconti di Samira Azzam troviamo quello delle lacrime.
Il racconto Il pane si apre con il soldato Ramiz che piange la morte dell’infermiera Suad, che, a sua volta nel corso del flashback, ci porterà al momento della sua morte e piangerà per il fratello, che ha deciso di lasciare il Paese per cercare un posto sicuro per la sua famiglia.
Il pianto è proprio al centro di Lacrime in vendita.
La figura di Khanza, una prefica, una donna che dietro compenso prende parte alle cerimonie funebri con canti e lamenti in onore del defunto, viene magistralmente descritta da una bambina che si intrufola a un funerale.
Khanza non piangeva solo quel morto, sembrava che piangesse tutti i morti del paese. Lamentazioni e urla rinnovavano il pianto delle altre donne al ricordo, chi di un marito, chi di un figlio o di un fratello. Non si capiva più quale era la moglie, la madre o la sorella del morto tra quelle donne. Quando erano stanche si calmavano per un po’, ma Khanza cominciava a recitare numeri in fila, per poi lanciare un altro dei suoi urli terrificanti facendo sì che le lacrime sgorgassero di nuovo, le voci si alzassero col pianto, e il dolore aumentasse. Khanza era al centro di tutto questo. La lingua era instancabile, la voce sembrava quella di una civetta. La sua capacità di fingere disperazione e dolore era straordinaria. La ricompensa sarebbe stata grande quanto lo sforzo profuso. La ricompensa di Khanza doveva essere enorme per ripagare tutta quell’infinita tristezza e quello struggimento disperato.
Ma piangere i defunti non è il solo lavoro di Khanza, che si occupa anche delle pettinature durante le nozze.
La narratrice spiazza il lettore catapultandolo delle bare contenenti i corpi dei defunti alla festa per eccellenza: il matrimonio. Attraverso un vero e proprio cambio di abiti da scena, Khanza si trasforma, sia nell’aspetto che nel modo di interagire con chi le sta intorno.
Quando la sera arrivavano le donne, tutte imbellettate e profumate, e si mettevano attorno al podio della sposa, i trilli di Khanza squarciavano il cielo. La sua bravura nel ballare, poi, era ben nota. Si aggirava tra le donne, scherzando con oscenità che le facevano scoppiare a ridere. Nel momento in cui lo sposo veniva a prendere la sposa, Khanza era alla testa del corteo, li seguiva fino alla porta della loro stanza e qui montava la guardia. Io non capivo perché Khanza se ne stesse lì, agitata e sulle spine, come aspettando qualcosa. Poi, come a un segnale, che poteva arrivare rapidamente o tardare un po’, Khanza lanciava un trillo strepitoso che, era chiaro, tutti aspettavano.
Khanza se ne andava contenta da ogni matrimonio, in attesa di poter festeggiare quello tanto atteso della figlia Masuda. Ma ciò non accadrà mai.
Con un altro salto repentino, siamo di nuovo davanti a una bara aperta, che contiene il corpo esanime della figlia di Khanza, morta di tifo. Ma contrariamente a quello che potremmo aspettarci a circondare la salma ora è solo il silenzio.
Non potevo resistere. Andai a casa sua con le tante donne che dovevano restituire una parte dei debiti che avevano con lei.
L’unica stanza della casa non poteva contenere più di venti persone. Molte donne erano rimaste sulla porta. Ma la voce di Khanza non si sentiva. Guardai al di là delle teste alla ricerca del suo viso. La vidi. Con mia somma sorpresa non piangeva.
Taceva, disperata e cupa, accovacciata per terra in un angolo della stanza. In testa non aveva la fascia nera, né l’indaco sulla faccia, non si batteva le guance né si strappava le vesti.
[…]
Alcune donne avevano accennato a piangere, a lamentarsi
Lei le aveva guardate con stupore, non capiva il perché della messa in scena. Si erano zittite, a loro volta incredule e stupite.
Quando vennero a portar via la salma, il corpo dell’unica creatura nei confronti della quale provava sentimenti non studiati, Khanza non pianse e non urlò. Guardava con occhi smarriti e attonita seguiva il corteo, in moschea prima e poi in cimitero. Anche nel momento dell’estremo addio aveva solo poggiato la testa sulla terra che aveva accolto il piccolo corpo, e lì era rimasta per ore.
Come nel racconto Il pane, la Nakba viene evocata anche ne La coperta rossa.
In una notte illuminata dalla luna argentata, un maestro di nome Hassan imbraccia un’arma carica degli ultimi colpi per rimandare l’inevitabile presa del villaggio di Battir.
Davanti a lui, oltre i binari, la scuola dove faceva il maestro sembrava un deserto morto, adesso, ben lontano dall’amore per la vita che cercava di inculcare nei suoi piccoli allievi; un posto arido, in disprezzo delle storie che raccontava prima dell’ora di ginnastica: “Guardate il monte, anche il monte sarà libero, saremo liberi anche noi”. Gli occhi salivano per la cima avvolta dalla luce del sole.
Qui, Hassan e sua moglie Suad hanno piantato il seme della loro speranza, un mandorlo nel giardino della casa degli avi, quando è nato loro figlio Omar.
Quando le munizioni finiscono, Hassan non può fare altro. Suad raccoglie pochi indumenti e la foto del loro matrimonio. Le braccia della madre sollevano Omar che continua a dormire. Insieme fuggono verso un rifugio sicuro.
Durante la corsa, i fischi dei proiettili nemici spezzano l’aria. Da dove provengono?
Suad inizia a rallentare. Che sia stata colpita? E’ bagnata di sangue. Da dove arriva tutto questo sangue?
Hassan capisce. Mentre Suad continua a rallentare, il maestro-soldato le toglie il figlio dalle braccia per consentirle di fuggire e inizia a correre veloce.
“L’aria è fredda, prendi questa coperta e avvolgigliela intorno!” Prese la coperta senza lasciare che gli vedesse la faccia, vi avvolse il piccolo e corse via.
[…]
Si chinò sul tenero viso, a baciarlo, parlargli, chiamario, finché la voce non gli rimase in gola, le lacrime si esaurirono e il bruciore gli infiammò gli occhi.
Riprese a scrollare il piccolo per riportarlo al miracolo della vita, ma le ciglia non battevano sulle palpebre socchiuse, su quegli occhi che erano stati vivi… per i quali aveva piantato il mandorlo…aveva preso il fucile…
[…]
Non aveva nessuna preghiera, il rancore lo rendeva muto.
Si trascinò via, camminò facendosi strada tra le folle dei profughi, cercando di rimanere calmo, di non inciampare nelle pietre della strada, sul braccio una piccola coperta umida che fino a due ore prima sapeva non essere stata rossa.
Il mandorlo forse continuerà a crescere e a fiorire nel giardino.
Per Omar non ci saranno più primavere.
I racconti brevi di Samira Azzam ci parlano di persone comuni e provano a rappresentare le sfaccettature e allo stesso tempo le ferite condivise di ogni palestinese.
In ciascuna delle ventidue storie viene narrata la vita di personaggi che non vengono riconosciuti, non hanno un nome e non sentono di possedere un’identità. La scrittrice cerca di dare un nome agli emarginati, analizzandone ricordi e memorie di sofferenze vissute e ingiustizie subite.
L’autrice usa un linguaggio concreto, descrivendo in maniera dettagliata eventi anche di estrema crudezza e crudeltà, dando importanza alle emozioni e alle parti del corpo come la mano, il cuore e in particolar modo gli occhi: è attraverso la descrizione fisica delle lacrime e del sangue che scorrono sui corpi dei vivi e dei morti che la scrittrice ci racconta il fluire della vita e del dolore; le stesse lacrime e sangue che diventano metafora di una collettiva oppressa, in un eterno ritorno della violenza degli occupanti, sempre uguale e sempre diversa, anche in quella che in questi giorni viene definita come una “seconda Nakba”.
Oriental Book Club è un podcast e un progetto di divulgazione letteraria indipendente pensato e scritto da Giulia&Frida. Si occupa di libri dal Mediterraneo, dal mondo arabo e persiano e dall’Asia.
Frida Susy Maria Morganti nasce e cresce nella provincia lucchese, si laurea in Lingua e letteratura araba all’Università di Pisa. Insegna materie letterarie nella Scuola Secondaria di I grado e si occupa di accoglienza linguistica per alunni neo-arrivati soprattutto da contesti arabofoni. Si impegna fermamente nella lettura ad alta voce nelle scuole. Continua a perdere diottrie leggendo libri, ama la cucina vegetale, ha un gatto di nome Syd.
Giulia Seclì, salentina di origine e pisana di adozione, dopo la laurea in Filologia semitica all’Università di Pisa e diverse esperienze di insegnamento nella Scuola Secondaria di I e II grado, vince un Dottorato Nazionale in Studi Religiosi (UniMoRe). Si occupa di ricezione della filosofia araba in contesto cristiano-siriaco nel XIII secolo. Ama i saggi prolissi, i film mistico-filosofici, il transfemminismo e i gatti.

Lascia un commento